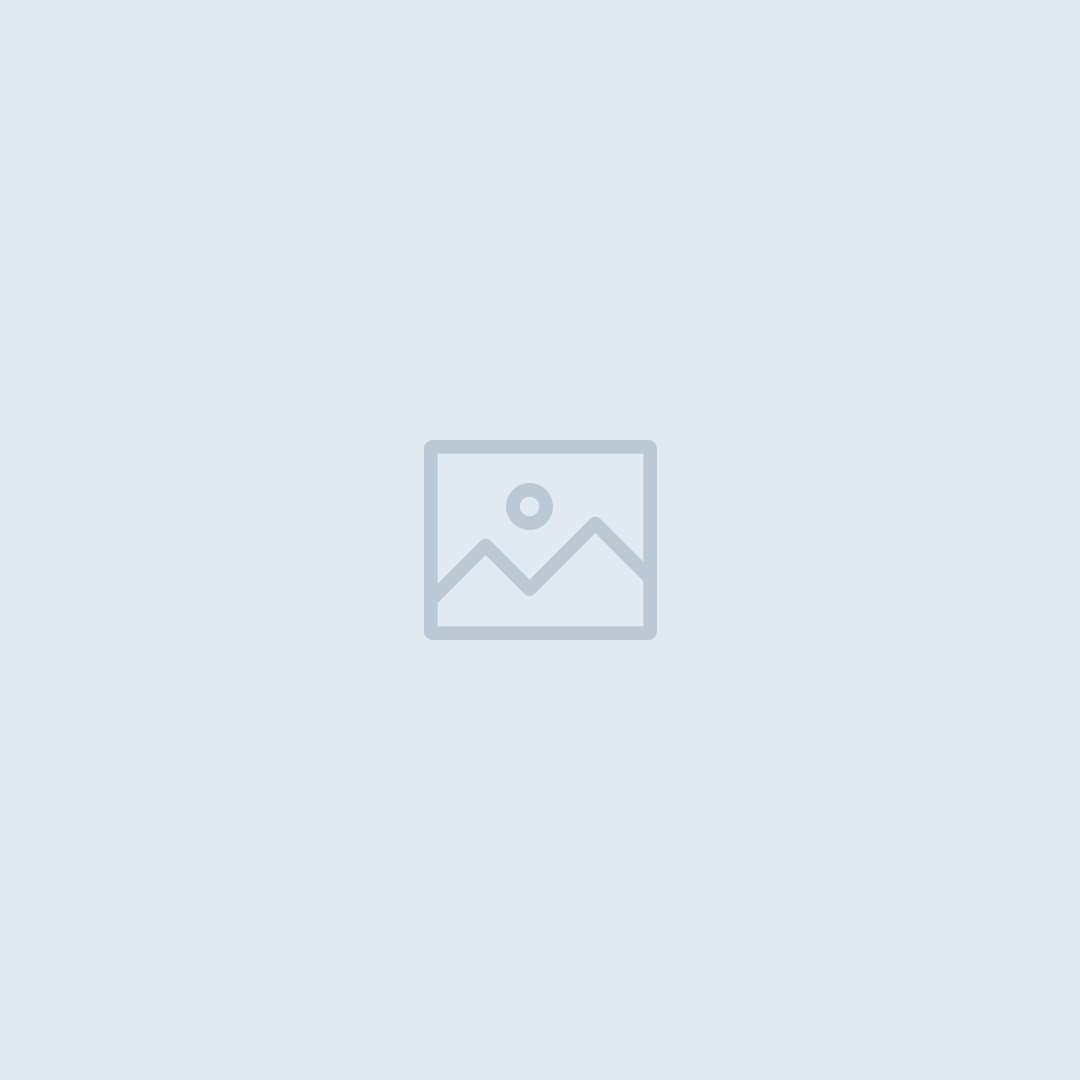Spesso avvolti nella nebbia, che ne rende ancora più impalpabile il contorno e quasi fiabesco l’aspetto, i colli Euganei si innalzano d’improvviso dalla pianura a sud di Padova. Gli inconfondibili profili conici e il verde intenso del loro manto rivelano l’origine vulcanica di questi modesti rilievi (altitudine massima 601 m),percorsi da una fitta rete di sentieri.
Ad accrescere la magia della zona, in corrispondenza dei colli emergono in superficie, concludendo un percorso sotterraneo iniziato dalle Piccole Dolomiti, acque termali molto rinomate legate ai nomi di Àbano Terme, Battaglia Terme e Arquà Petrarca. Dalle meraviglie della natura a quelle dell’uomo, Este, Monsélice e Montagnana, incoronate da mura medievali, costellano il paesaggio ancora disegnato dalle canalizzazioni della Serenissima.
A una decina di chilometri da Padova sorge [B]Àbano Terme[/B], città d’acque universalmente famosa, di architetture novecentesche eclettiche e floreali. Non esiste, qui, uno
stabilimento curativo principale: ciascuno degli oltre cento pozzi di acque mineralizzate viene fatto sfiatare in corrispondenza di ogni singolo albergo. La conseguenza è una struttura dell’abitato priva di centro. La vita gravita sul viale delle Terme, che unisce l’area del più
antico insediamento (dominato dal millenario Duomo) all’espansione moderna. La via Pietro d’Abano conduce al piccolo rilievo di Montirone da cui sgorgava una delle sorgenti più calde del bacino termale; al n. 20 è allestita la Pinacoteca civica al Montirone, con autori di scuola veneta e lombarda. L’area archeologica della vicina Montegrotto Terme testimonia l’impiego delle acque curative fin dall’antichità; oggi le attrattive del centro sono il verde e le piscine degli alberghi.
Importante per il suo ruolo di città fortificata, oltre che per le virtù termali e per le tradizioni manifatturiere, è Battaglia Terme. Precede il centro il Cataio (1570-73), imponente complesso residenziale turrito e merlato del condottiero della Serenissima Pio Enea I degli Olbizzi. Il sito è allungato sulle rive del canale
della Battaglia, che i padovani scavarono alla fine del XII secolo per mettere in comunicazione Padova, la Laguna e Venezia, e la cui corrente, nei secoli XIII e XIV, ha
azionato mulini e dato energia alla seconda cartiera della penisola. Intorno, sullo sfondo dei colli Euganei, fanno capolino antiche ville patrizie; tra queste, villa Selvatico-Capodilista, costruita a ridosso delle terme nei secoli XVIXVII in forme palladiane, si erge su una
scenografica scalinata della metà del ’600 che la collega a un parco di gusto romantico. Un altro splendido giardino, questa volta all’italiana, circonda la cinque-seicentesca villa Barbarigo di Valsanzibio, vicino a Galzignano.
L’abitato di [B]Arquà Petrarca[/B] (m 80) e il suo contesto collinare sono poco mutati da quando Francesco Petrarca (1304-74) li scelse per trascorrervi gli ultimi quattro anni di vita ed esservi sepolto: morì settantenne con il panorama dei colli Euganei negli occhi, nella
casetta che si era costruito tra un uliveto e una vigna. L’impianto medievale è ben conservato attorno alla piazza-sagrato al centro del paese, sulla quale prospettano edifici quattrocenteschi: qui dal 1389 sorge su bassi
pilastri il grande sarcofago della tomba di Petrarca. Dietro il sepolcro è la parrocchiale di S. Maria, di origine medievale ma rimaneggiata, che conserva una tela di Palma il Giovane. Da qui si sale per via Roma fino al
giardinetto a bosso che cinge la casa di Petrarca: eretta nel XIV secolo come esempio perfetto dell’ideale vita solitaria ricercata dal poeta, fu ampliata nel ’500 e restaurata nel XX secolo. A sinistra della sala, dal soffitto trecentesco, si aprono le porte della camera da
pranzo e dello studio; sulla destra la sala del camino e la camera cosiddetta “delle visioni”.
[B]Monsélice[/B], cittadina ambita già in epoca romana quando si chiamava Mons silicis (monte di selce), attirò le attenzioni della municipalità padovana e del vicario imperiale Ezzelino da Romano, a cui si dovette la
costruzione della prima vera cerchia fortificata (1239), poi ampliata dai Carraresi: pochi tratti sono sopravvissuti agli abbattimenti del XIX secolo dovuti al successo delle manifatture tessili e dell’estrazione di trachite. Per celebrare l’ingresso della regione nel nuovo
Stato italiano, fu ricavata nel 1870 la quadrata piazza Mazzini, risparmiando alle demolizioni la loggetta cinquecentesca di quella che è oggi la Biblioteca comunale e la duecentesca Torre civica, ridotta a campanile. Oltrepassato il ponte della Pescheria, gettato (1559) sul
canale presso cui rimangono tratti delle mura carraresi, via Belzoni conduce a villa Pisani, eretta a metà ’500 su disegno di Andrea Palladio. La suggestiva via al Santuario, che sale verso il colle incontrando i monumenti più importanti, si apre nello slargo su cui affaccia
lo storico castello, notevolissimo complesso originario dei secoli XI-XII. Lasciate a sinistra la scenografica scalea a terrazze e le statue grottesche di villa Nani-Mocenigo (secolo XVI), si giunge al Duomo vecchio: intitolato a santa Giustina, fu costruito in forme romaniche nel 1256 e restaurato nel 1935. Dietro la semplice facciata con protiro quattrocentesco, l’interno
custodisce resti di affreschi del ’400 e un polittico coevo veneziano. Dal retrostante settecentesco piazzale della Rotonda si entra nel santuario delle Sette Chiese, che consta di sei cappelle disegnate nel 1605 da Vincenzo
Scamozzi (i dipinti sono di Palma il Giovane) e della chiesetta di S. Giorgio. Al termine del viale prospetta villa Duodo, pure di Scamozzi (1593), ampliata sulla fronte nel ’700, quando fu eretta anche la monumentale scalea di accesso al giardino all’italiana. Sul colle
domina la rocca, inaccessibile, voluta da Federico II e rinnovata dai Carraresi, da cui si gode uno splendido panorama.
A [B]Este[/B] si spengono nella pianura le ultime ondulazioni dei colli Euganei; il profilo architettonico e la scena urbana sono dominati dal castello carrarese, con la sua cinta intatta,e dal costruire che fecero, tra ’600 e ’700, le nobili famiglie veneziane. Le origini della
cittadina chiamata Ateste (forse dall’Athesis o Adige che la bagnava) risalgono a IX e VIII secolo a.C.; attorno al Mille vi si affermarono gli Este che ereditarono il nome proprio da questo centro, il maggiore della Bassa a sud di
Padova. Dal mastio in vetta al colle scende la scenografica cortina a torri voluta dai Da Carrara (1339-40), che cinge un pendio oggi giardino pubblico. A valle, nell’ala superstite di palazzo Mocenigo, trova posto il Museo nazionale atestino, eccezionale collezione archeologica: la sezione preromana documenta la preistoria della città e degli Euganei dal Paleolitico all’età del Ferro; la sezione romana tratteggia invece la storia successiva; una sala espone opere medievali e moderne, tra cui una Madonna col Bambino (1504) di Cima da Conegliano. Da piazza Maggiore, su cui affaccia il palazzo del Municipio ricostruito nel ’600, i portici di via Principe Umberto avviano alla chiesa romanico-gotica di S. Martino (XI secolo), con campanile duecentesco, e a S.Maria delle Grazie, o Madonna della Salute, sorta nel 1717 su un santuario del XV secolo; all’interno, ritmato da grandi statue di metà ’800, si conserva l’immagine bizantina del XV secolo la cui fama miracolosa convinse gli Este a erigere la chiesa. S. Maria delle Consolazioni, detta anche degli Zoccoli (inizio del ’500); la cappella della Vergine conserva un magnifico pavimento musivo romano
proveniente da un vicino scavo. Superato di nuovo il canale di Este e varcata porta S. Francesco (1581), ci si trova di fronte al Duomo, ricostruito da Antonio Gaspari dopo che nel 1688 un terremoto aveva abbattuto il precedente tempio paleocristiano. Il grandioso interno a pianta ellittica ha ricca dotazione statuaria e pittorica, culminante nell’abside con la grande pala di Giambattista Tiepolo (1759). Via dei Cappuccini porta, sul colle, al
cosiddetto arco di Falconetto, che dava accesso alla villa qui voluta nel ’500 dai Cornaro. Il complesso apre una serie di residenze nel verde: da vedere villa Kunkler,
dove George Byron e Percy Bysshe Shelley soggiornarono nel 1817-18, e il tardocinquecentesco palazzo del Principe,
cosiddetto perché Alvise Contarini fu eletto doge (1676) mentre vi risiedeva.
A [B]Montagnana[/B], in presenza di un complesso fortificato tra i meglio conservati al mondo (2km di cerchia murata), può succedere di sentirsi catapultati indietro nel tempo. Le ventiquattro torri che scandiscono le mura medievali sono aperte verso l’interno; nella
planimetria le principali interruzioni corrispondono alla rocca degli Alberi o porta Legnago e a porta Padova o al castello di S. Zeno, fatto costruire nel 1242 da Ezzelino da Romano e ridotto dalla Serenissima a deposito di canapa, le cui mura in cotto ospitano oggi il Museo civico. Fu il nobile veneziano Andrea Pisani a far costruire extra moenia, su disegni di Palladio, palazzo Pisani (1553-55); nell’atrio a colonne dominano le Quattro Stagioni di Alessandro Vittoria (1565-77).
L’asse viario che dal castello di S. Zeno attraversa l’abitato prende nel primo tratto il nome di via Carrarese, lasciando a sinistra il severo palazzo del Municipio (disegno attribuito a Michele Sanmicheli, 1538), e aprendosi sul lato opposto, nello slargo centrale, a portici che tracciano una suggestiva prospettiva del Duomo. Iniziato nel 1431 e concluso da Lorenzo da Bologna nel 1502 in sostituzione di una chiesa d’epoca romanica, il Duomo custodisce nell’interno rinascimentale numerose opere d’arte, tra cui due pale di Giovanni Buonconsiglio (inizi del ’500), Assunzione della Vergine, forse del
medesimo autore, e Trasfigurazione di Paolo Veronese (1555) sull’altare maggiore attribuito a Jacopo Sansovino. La chiesa di S. Francesco, infine, conclusa nel ‘400, conserva una Trasfigurazione della scuola di Veronese e una
Madonna col Bambino di Palma il Giovane.
Tornando verso il capoluogo, merita una deviazione l’abbazia di Praglia,monumentale complesso benedettino fondato nel XII secolo e riedificato nei secoli XV-XVI
in un angolo suggestivo dei colli Euganei.
Una scalea precede la chiesa dell’Assunta (1490-1560), scortata da un campanile romanico, unico resto della chiesa originaria. Sul fianco destro della chiesa è l’ingresso al monastero, con il chiostro botanico da cui si
accede a un chiostro pensile, quindi al refettorio grande con stalli lignei settecenteschi e una Crocifissione di
Bartolomeo Montagna (1499-1500). Di grande impatto il chiostro doppio a portico e loggia,costruito nel 1461.