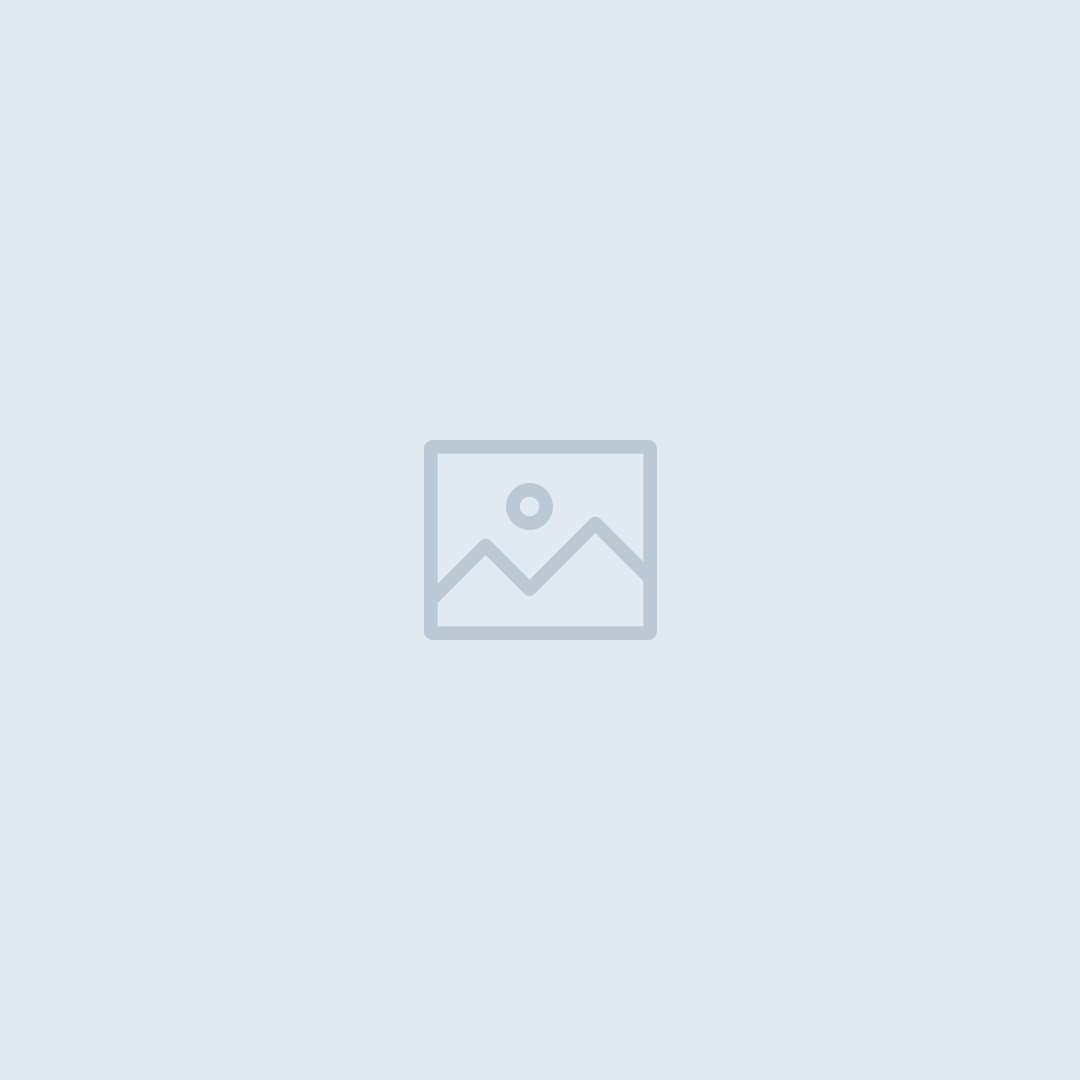Città d’arte e “città d’autore”, ma anche città del bel vivere e dei sapori territoriali, Vicenza (m 39; ab. 110.000 ca.) si estende nella dolce pianura veneta, ai piedi dei colli Bèrici. Nel ’500 Andrea Palladio le ha conferito un volto unitario e inconfondibile, permeandola di una bellezza classicistica che ben si accorda a frammenti goticoveneziani e a un’altra Vicenza minore, di ponti e canali, scorci romantici, aperture improvvise su colli e prealpe. La città è tutelata dall’UNESCO appunto per il suo patrimonio palladiano.
Il centro monumentale, in gran parte chiuso al traffico, consiste in un sistema articolato di tre piazze (dei Signori, delle Biade, delle Erbe) e nella piazzetta Palladio, tutte ruotanti attorno alla fabbrica della Basilica. L’area corrispondeva nel medioevo al Peronio, cuore politico e sociale della città, in cui avevano sede i principali edifici pubblici.
[B]Piazza dei Signori[/B] è il fulcro della passeggiata nel cuore di Vicenza: qui sorgono il prospetto del cinquecentesco palazzo del Monte di Pietà, che incorpora la facciata barocca della chiesa di S. Vincenzo (1389), e la loggia del Capitaniato, incompiuta (1571-72), che nei progetti di Palladio doveva inglobare l’isolato e risulta così fuori scala rispetto alla Basilica (1546-1614). L’edificio, che delimita il lato sud della piazza, è uno dei più rappresentativi del rinascimento veneto: Palladio incastonò il preesistente quattrocentesco palazzo della Regione in un sontuoso rivestimento marmoreo di forme classiche; centro della composizione è la serliana, elemento-finestra che corregge, con il ritmo di archi e architravi, l’irregolarità degli edifici gotici. Nella
retrostante piazza delle Erbe si alza, unica testimonianza delle architetture medievali, la torre del Girone o del Tormento. All’angolo settentrionale della Basilica svetta (m 82) la snella torre di Piazza (secoli XII-XV), a cui si
addossano i tre corpi di fabbrica del palazzo del Podestà che affacciano sulle piazze dei Signori e delle Biade.
Asse del centro monumentale è [B]corso Palladio[/B], decumano massimo della romana Vicetia, con la sua scenografica quinta architettonica di edifici dei secoli XIV-XVIII: partendo da piazza Castello palazzo Thiene, poi Bonin-Longar, chiaro esempio, pur nella sua incompiutezza (1545-74), di come Palladio sapesse imporre un disegno non congruente con il tessuto urbano; palazzo Trissino-Baston (1592), capolavoro di Vincenzo Scamozzi, oggi sede del Municipio e dell’Accademia Olimpica; palazzo Dal Toso-Franceschini-Da Schio (1477), gioiello dell’architettura tardogotica vicentina; palazzo Marcantonio Valmarana (1593), esempio di stile severo di marca scamozziana.
Poco oltre, la casa Cogollo (1559-62) annuncia piazza Matteotti, ampio spiazzo verde su cui sorgono due attrattive di spicco della visita alla città: il Teatro Olimpico e palazzo Chiericati (Palladio, 1550), sede del [B]Museo civico-Pinacoteca[/B]. Pregevoli i soffitti affrescati di tre sale al pianterreno che ospitano capolavori di Filippo De Pisis, Ottone Rosai, Gino Severini, Ardengo Soffici, Carlo Carrà. La sezione di arte medievale, al secondo piano, conserva opere che vanno dal XII al XIV secolo, fra cui Dormitio Virginis di Paolo Veneziano, Calvario di Hans Memling, Adorazione dei Magi di Bernardino Luini. La Pinacoteca, dedicata soprattutto al ’500 veneto, vanta, fra gli altri, dipinti di Cima da Conegliano, Paolo Veronese, Jacopo Tintoretto, Jacopo Bassano; di notevole interesse anche la sezione sul ’600 e il ’700, con Francesco Maffei, Sebastiano e Marco Ricci, Pietro Muttoni, Giambattista Tiepolo, Giambattista Piazzetta. Tra i pittori di altre scuole, i fiamminghi Hans Memling (Crocifissione) e Van Dyck (Le tre età dell’uomo); notevoli una Madonna col Bambino, terracotta di Jacopo Sansovino, e la raccolta di disegni di Palladio.
Sulla stessa piazza, nel perimetro del medievale castel S. Pietro sorge il [B]Teatro Olimpico[/B], ultima straordinaria creazione di Palladio (1580), compiuta dal figlio nel 1583. Annesso al teatro è l’Odeo, luogo di riunione dell’Accademia degli Olimpici, realizzato da Scamozzi nel 1608, con pareti affrescate da Maffei; segue l’Antiodeo, da cui si accede al teatro costruito in legno e stucco su modello dei teatri classici antichi: ha cavea di gradoni semiellittici e una fastosa scena a due ordini corinzi.
Da piazza Matteotti, percorrendo stradella Teatro Olimpico si entra in [B]contra’ S. Corona[/B], dominata dalla chiesa domenicana di S. Corona (1260-70). L’interno ha profondo presbiterio rinascimentale sopraelevato, alla cui destra si apre la cappella Valmarana di Palladio; il primo altare a sinistra inquadra il Battesimo di Gesù, capolavoro di Giovanni Bellini. Il monastero domenicano ospita le sezioni naturalistica e archeologica del Museo civico: la prima fornisce un quadro dell’ambiente bèrico, la seconda espone raccolte dal Paleolitico all’alto medioevo.
Al n. 25 di contra’ S. Corona si trova [B]palazzo Leoni Montanari[/B], una delle poche testimonianze di barocco civile, oggi sede di una banca e di una rilevante collezione d’arte che comprende opere di Pietro Longhi, Canaletto, Francesco Guardi.
Percorrendo corso Fogazzaro, una delle vie più animate della città su cui spicca, al n. 16, il solenne [B]palazzo Valmarana-Braga[/B] (1566) di Palladio, si giunge all’imponente chiesa francescana di S. Lorenzo, di forme gotiche (secolo XIII), con un interno a tre navate arricchito da una decorazione molto articolata (secoli XV-XVII). A due passi, il Duomo, fondato nel V secolo ed eretto nelle forme attuali dal XIII al XVI, con facciata gotica a marmi policromi e un’elegante abside rinascimentale. Dal corpo emergono l’armonica tribuna di Lorenzo da Bologna e la cupola di Palladio (1574); all’interno dipinti e sculture dal ’300 al ’700.
L’anello edilizio a ridosso del nucleo più antico è composto da borghi con tratti piuttosto definiti: a nord-ovest il borgo S. Croce con le mura scaligere e la basilica dei Ss. Felice e Fortunato, ricostruita fra X e XII secolo sul sito di un luogo di culto paleocristiano; a ovest il quartiere S. Rocco che lambisce il lato nord del giardino Salvi; a nord-est, oltre il Bacchiglione, borgo S. Lucia, con le abitazioni settecentesche degli artigiani della seta; borgo S. Pietro, che si organizzò attorno al convento benedettino; infine, il rione Barche, che fu il porto della città.
Nella fascia sudorientale si visitano infine i quartieri in riva al Retrone, già abitati in epoca romana, con la gotica casa Pigafetta.
La visita della città termina con tre monumenti collinari. A sud si imbocca viale X Giugno, affiancato per 700 m da un portico con cappelle, progettato (1717) da Muttoni per accompagnare il pellegrino fino alla basilica di Monte Bèrico. Questa, sorta come chiesetta gotica in un luogo di
miracolose apparizioni della Vergine, venne ampliata nel 1480 e poi inglobata nella costruzione barocca di Giacomo Borella (1687-1703), cui funge da presbiterio. L’esterno è a pianta quadrata, al centro della quale si levano tamburo e cupola; le tre facciate barocche hanno corpo centrale sporgente concluso da un timpano curvo. Nell’elegante interno a croce greca è custodita la venerata statua della Madonna di Monte Bèrico di Nicolò da Venezia (inizi XV secolo), meta di pellegrinaggi; il refettorio custodisce la Cena di san Gregorio Magno (1572), grande tela di Veronese.
Dalla balconata dell’antistante piazzale della Vittoria si gode una splendida vista su Vicenza e le montagne. Allo snodo di viale X Giugno, sulla spianata del Cristo, si dirama viale d’Azeglio che porta a villa Bertolo-Valmarana “ai Nani” (1665-70, con successivi interventi del 1736), laicissima bibbia della pittura del ’700: nel 1757 furono chiamati a decorarla Tiepolo e il figlio
Giandomenico. La palazzina ospita cicli di scene dedicate all’Iliade, all’Orlando Furioso, all’Eneide e alla Gerusalemme liberata.
Più avanti sulla stessa strada, conclude questo itinerario collinare il capolavoro di Palladio, villa Almerico-Capra, più nota come[B] la Rotonda[/B]. Iniziata nel 1567, alla morte dell’architetto era ancora incompleta nella parte superiore; fu Scamozzi, nel 1606, a realizzare la cupola che copre il salone circolare al piano nobile. Proprio questa “rotonda” è il centro nevralgico della composizione, alla quale Palladio impresse forza centrifuga allungando la sala centrale verso l’esterno, nei quattro pronai ionici e nelle scalinate. La villa è così un’architettura aperta, che guarda la città e la campagna.